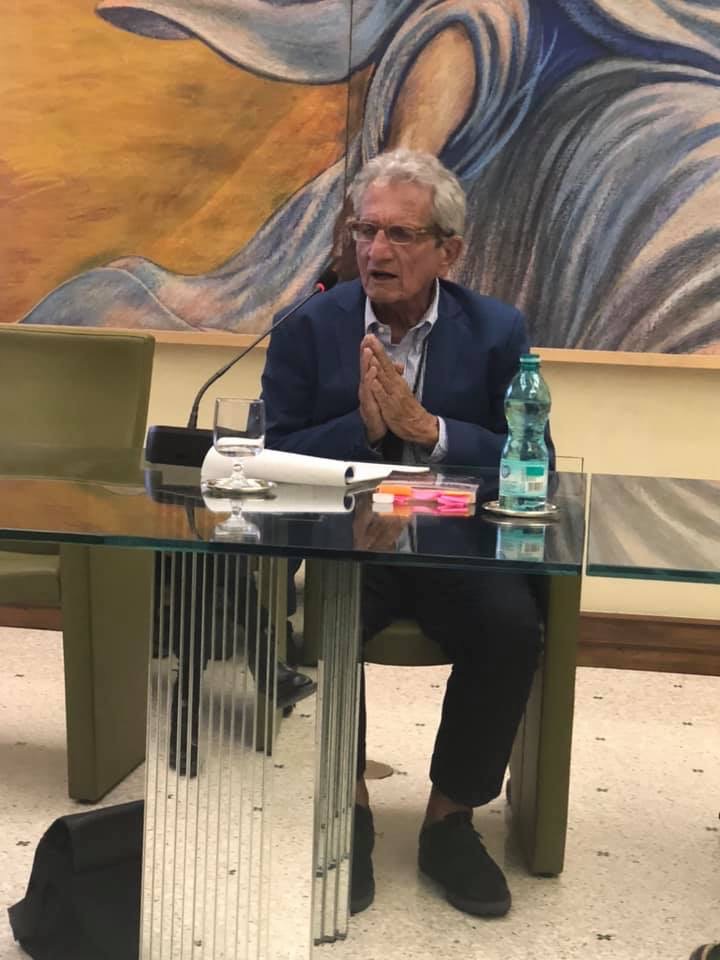Cassata.
Nel tardo pomeriggio di giugno il sole dardeggiava ancora implacabile sulle facciate dei palazzi lungo la via che costeggia il porto. Dal mare spirava un’aria flebile, troppo debole perché potesse dare sollievo alla calura, recata da giorni di venti africani e intrisa di umidori mediterranei. Sotto il porticato sciabolate di sole si infilavano fra le colonne di granito e le tende a grandi righe, tese ad attenuare la luce abbagliante del tramonto. Nella lunga galleria i tavolini dei bar formavano un’unica sequenza, interrotta solo dalle strade che,a intervalli regolari, dal quartiere della Marina, si immettono nel grande viale, aprendosi al mare. Vi sedevano perennemente perdigiorno di diversa estrazione e, al termine del lavoro negli uffici o, per altri, dopo la robusta siesta estiva, clienti della borghesia impiegatizia e professionale. I signori erano convenientemente vestiti, in fresco di lana grigio chiaro o noisette, cravatta chiara. Qualcuno calzava addirittura scarpe bicolori adatte alla stagione. Bianche e marroni. Le signore eleganti, non molte, esibivano abiti di seta e cappelli di paglia. Gli uomini leggevano il giornale e lo commentavano ad alta voce. Poi lo riponevano, piegato, nella tasca della giacca da cui spuntava per gran tratto. I camerieri si spostavano solleciti dall’area dei tavolini all’interno dei caffè passando l’ordinazione, la “comanda”, con voce stentorea. C’erano infatti diversi caffè, frequentati in tutte le stagioni. Persino in quella relativamente fredda dell’inverno i tavolini all’aperto non erano ritirati. Il periodo d’oro andava però da maggio a ottobre, anche se fasi di grande animazione si ripetevano intorno a Natale e a Pasqua. Soprattutto la Pasqua era occasione, per i bravi pasticceri operanti sotto il colonnato della Via Roma, di dare prova di perizia e fantasia nel costruire grandi e spettacolari uova di cioccolato. Mettevano su una curiosa animazione con veri pulcini che, in vetrina, circolavano zampettando e pigolando intorno a un grande uovo-casa di cioccolato decorato. Una festa, per noi bambini, che schiacciavamo il naso sulla vetrina per ore. Ammiravamo e vivevamo desideri che, sapevamo, sarebbero rimasti quasi sempre insoddisfatti. La società dei consumi era di là da venire, e la ripresa del dopoguerra consentiva appena l’accesso a beni di più stretta necessità rispetto alla proposta delle grandi uova pasquali. Per me la vera attrazione di quel luogo era costituita, però, dalla cassata. Intanto perché la cassata si assaporava seduti al tavolino, circostanza che per me si verificava assai di rado. Sedere al bar era dispendioso, occorreva consumare e nel parco bilancio piccolo borghese tale eventualità non era contemplata se non eccezionalmente. Mio padre però, di tanto in tanto si prendeva il gusto di una sosta per un caffè per lui e un gelato per me. Non saprò mai se la sosta al tavolino rispondeva a un suo desiderio o se invece era frutto delle mie pressanti sollecitazioni. Il fatto è che io ambivo molto sedermi al tavolino e, appagamento massimo, gustare la cassata. Credo che questa ventura mi sia occorsa una o due volte. Costava cara. E poi, un ragazzino che consuma la cassata, andiamo…. Mi affascinava la procedura e la seguivo incantato, anche quando riguardava i vicini di tavolo. In genere però mi era riservata una coppetta di carta cerata contenente un gelato di crema e cioccolato. Il babbo ordinava un caffè. Il servizio era portato su un vassoio d’acciaio, lucido. Il gelato e il caffè o, rarità, la cassata, erano accompagnati da un bicchiere d’acqua da bere, mentre un altro bicchiere, anch’esso riempito d’acqua, conteneva i cucchiaini. Quando giungeva il momento, la cassata era offerta su un piattino, adagiata su una di carta per pasticceria, con una sorta di pizzo o merletto all’intorno. Il che rappresentava, per lo meno ai miei occhi, il riconoscimento della regalità di quella meraviglia. Consumarla era un peccato, ma non per il cedimento alla gola, quanto piuttosto per la profanazione della perfetta confezione. Aveva un aspetto splendido, con i suoi strati di diverso colore, il pan di spagna intriso di liquore, l’inserto cremoso, i frutti canditi multicolori, incastonati nel bianco, da scoprire con delicata opera di scavo. Per gustarla bene era opportuno non affrettarsi, trovare il giusto ritmo però, per evitare che il calore implacabile sciogliesse tutto prematuramente. Al termine dell’accurato adoprarsi del cucchiaino restava, sulla carta ricamata, qualche labile residuo e un senso di sciupato e appiccicaticcio. Era il momento di utilizzare il bicchiere d’acqua che aveva accompagnato la cassata. Un bel sorso d’acqua fresca concludeva il rito. Tutto qui. La cassata aveva compiuto la sua parabola, inconsistente. Io, ragazzetto magrolino e abbronzato dal lungo giocare nel campetto dell’oratorio, avevo avuto accesso a quello spazio ammirato ed effimero del caffè per il rito della cassata. Mio padre aveva terminato da molto il suo caffè.
Franco Mannoni